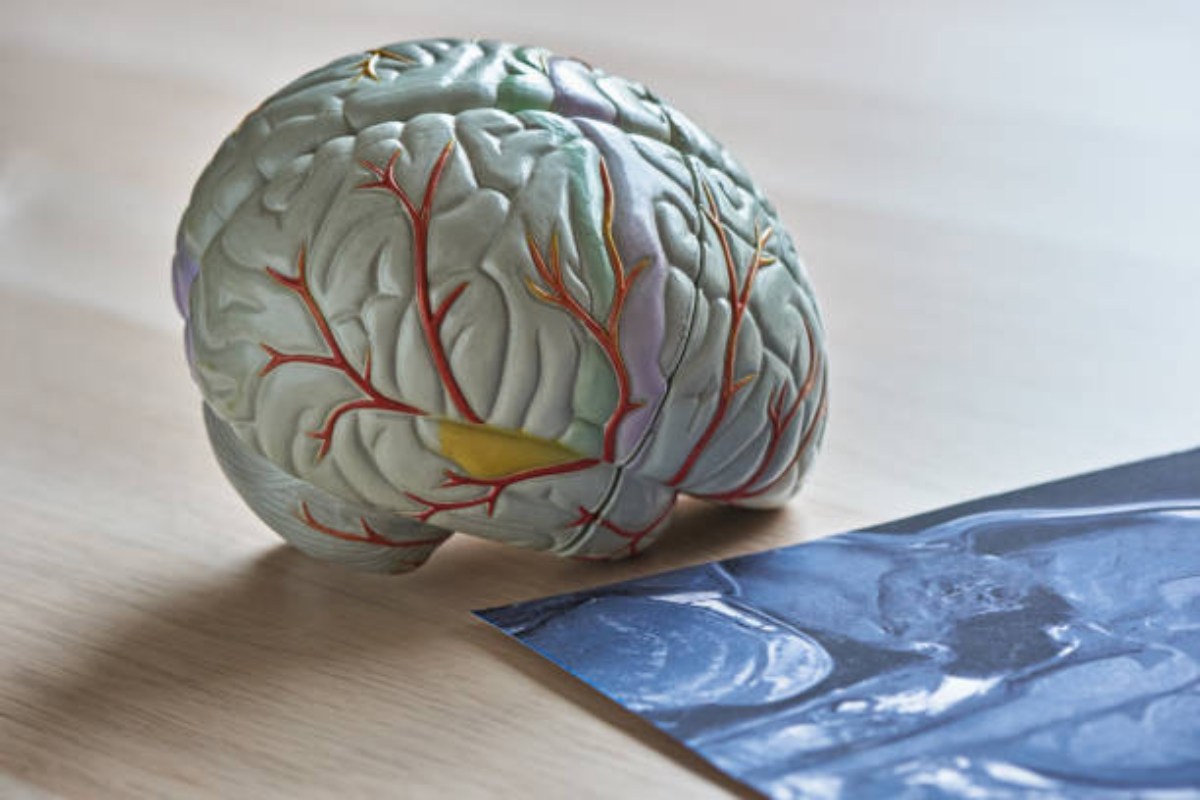Le 5 età del cervello: un nuovo studio di Cambridge traccia le tappe chiave dello sviluppo cerebrale. Tutto ciò che c’è da sapere a riguardo
Il cervello umano si sviluppa e invecchia attraverso cinque fasi distinte, ognuna caratterizzata da profonde trasformazioni nelle connessioni neuronali. Questa complessa evoluzione è stata mappata da uno studio pubblicato su Nature Communications e condotto da Alexa Mousley dell’Università di Cambridge, che ha analizzato oltre 3.800 soggetti, dai neonati fino ai novantenni, tramite risonanza magnetica. Le evidenze scientifiche delineano cinque età del cervello, intervallate da quattro momenti di svolta cruciale, che ne definiscono la struttura e le capacità cognitive nel corso della vita.
Le cinque età del cervello: dalla plastica infanzia all’età adulta
Durante l’infanzia, che dura fino a circa 9 anni, il cervello vive una crescita dinamica di materia grigia e bianca, con un’abbondanza di connessioni sinaptiche che vengono selezionate e consolidate. Questa fase è fondamentale per la formazione delle reti neurali ma è anche un periodo di vulnerabilità, con un aumento del rischio di disturbi mentali. L’adolescenza, estesa fino ai 32 anni, è caratterizzata dall’ottimizzazione delle reti di comunicazione cerebrale. Qui la materia bianca continua a svilupparsi, migliorando la rapidità e l’efficienza delle connessioni neuronali, con un picco di maturità strutturale che supera le tradizionali aspettative legate all’età adulta precoce.
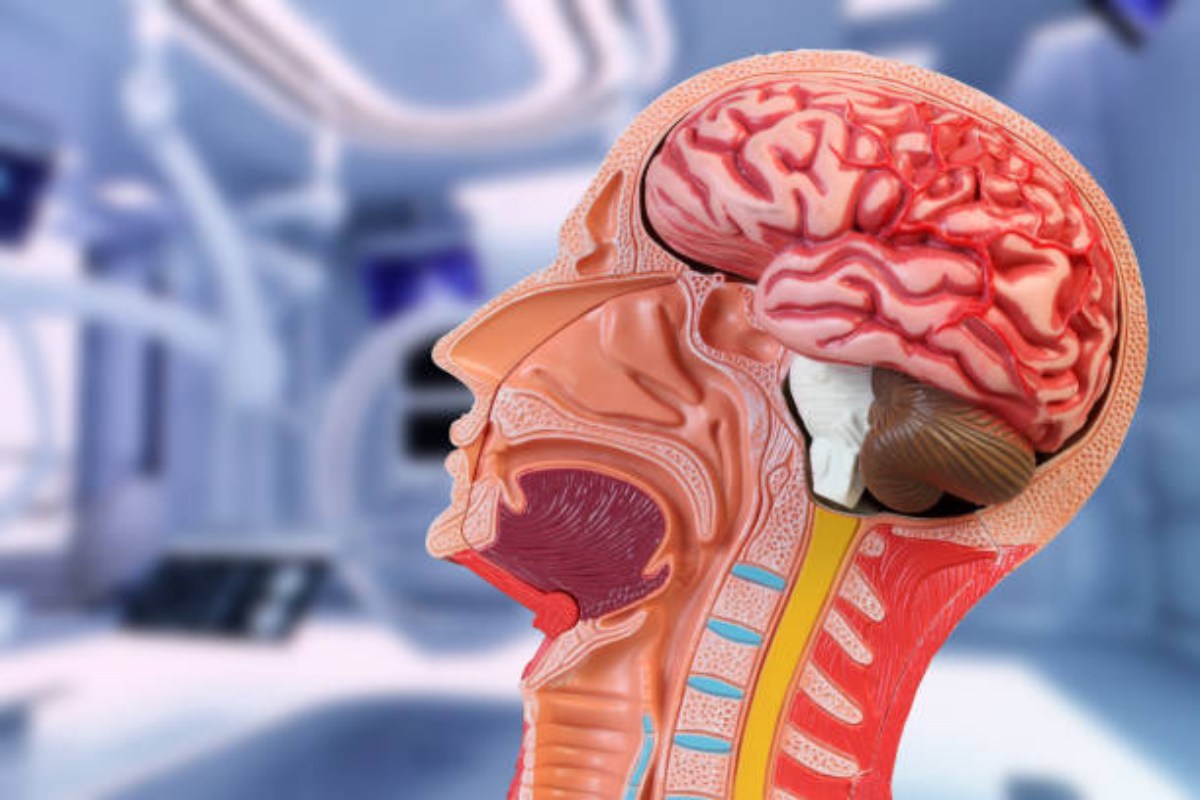
Il passaggio ai 32 anni segna il più significativo cambiamento nella traiettoria cerebrale, dando inizio a un lungo periodo di stabilità neurale che dura circa trent’anni. Questa fase adulta è caratterizzata da un plateau nelle capacità cognitive e nella personalità, con una struttura cerebrale che si mantiene relativamente costante senza grandi mutamenti. Successivamente, due ulteriori svolte si verificano attorno ai 66 e agli 83 anni, segnando l’inizio di un declino più graduale e di una progressiva riorganizzazione delle reti cerebrali, che tendono a fare affidamento su circuiti più locali in età avanzata.
Superager: il cervello che sfida l’invecchiamento
Parallelamente alla comprensione delle fasi cerebrali, ricerche prolungate condotte dalla Northwestern University di Chicago hanno individuato il fenomeno dei cosiddetti superager: anziani ottantenni con capacità cognitive paragonabili a quelle di persone di 20-30 anni più giovani. Questi individui mostrano un cervello con volumi corticali più simili a quelli di cinquantenni, una corteccia cingolata particolarmente spessa e una minore presenza di alterazioni tipiche dell’Alzheimer, come i grovigli di proteina tau nell’ippocampo. Inoltre, il sistema immunitario cerebrale, rappresentato dalla microglia, appare più efficiente e meno infiammatorio rispetto ai coetanei.
I superager si distinguono anche per caratteristiche psicologiche e sociali: sono persone molto socievoli, attive nelle comunità e con un forte senso di autonomia. Questi tratti sembrano offrire una protezione aggiuntiva contro il deterioramento cognitivo, anche in presenza di fattori di rischio cardiovascolare o stili di vita non sempre salutari. Le ricerche suggeriscono che una combinazione di fattori genetici e ambientali contribuisce a questo fenotipo di longevità cognitiva, aprendo la strada a potenziali interventi per rallentare il declino cerebrale tipico dell’invecchiamento medio.
La memoria e il ruolo dell’ippocampo nel consolidamento
Un altro aspetto cruciale nel funzionamento cerebrale riguarda la formazione dei ricordi. Il processo inizia con l’attivazione di neuroni che formano connessioni sinaptiche, creando la traccia mnestica iniziale. L’ippocampo svolge un ruolo centrale nel decidere quali informazioni vengano consolidate a lungo termine, agendo come un filtro e un elaboratore delle memorie. Il consolidamento rafforza queste connessioni, rendendo i ricordi stabili e recuperabili nel tempo.
La memoria si articola in diverse tipologie: episodica, semantica, operativa, procedurale e implicita, ciascuna con funzioni specifiche. Emozioni intense aumentano la probabilità di memorizzazione, mentre fattori esterni come qualità del sonno e stress influenzano il consolidamento. Disturbi neurodegenerativi come l’Alzheimer interferiscono con questi processi, sottolineando l’importanza di comprendere le basi neurologiche della memoria per sviluppare strategie di prevenzione e cura.