Alcuni disturbi ormonali e neurologici possono alterare la percezione della fame: ecco cosa ha spiegato un noto endocrinologo italiano.
Succede a molte persone: mangiano regolarmente, in certi casi anche abbondantemente, eppure dopo poco sentono di nuovo il bisogno di masticare qualcosa. Non si tratta di golosità o mancanza di forza di volontà, come spesso si crede. Secondo alcuni studi clinici condotti negli ultimi anni, la fame continua può essere legata a squilibri ormonali, disturbi metabolici o condizioni neurologiche che interferiscono con i segnali di sazietà. A dirlo è Giuseppe D’Alessio, endocrinologo del Policlinico di Milano, che ha seguito più di 400 pazienti affetti da disturbi alimentari non patologici.
Molte delle persone che si rivolgono a lui lo fanno dopo aver tentato di seguire diete standard senza risultati. “In certi casi, ci troviamo davanti a soggetti che non riescono a smettere di mangiare non perché non vogliano, ma perché il loro corpo continua a inviare segnali sbagliati”, spiega il medico. Il centro del problema, dice, è spesso legato a leptina, grelina e insulina, tre ormoni che regolano l’appetito e che possono essere alterati da vari fattori, tra cui stress cronico, mancanza di sonno o un’errata alimentazione protratta nel tempo.
Le cause ormonali e neurologiche del senso continuo di fame
La grelina è uno degli ormoni principali coinvolti nel meccanismo della fame. Viene prodotta dallo stomaco quando è vuoto e invia un segnale all’ipotalamo per stimolare il desiderio di cibo. In condizioni normali, dopo il pasto la grelina si abbassa e entra in gioco la leptina, che segnala al cervello che si è sazi. Ma quando questo meccanismo si rompe o si altera, il segnale non arriva oppure arriva distorto. “Ci sono persone che hanno livelli cronici alti di grelina, oppure che sviluppano una sorta di resistenza alla leptina”, sottolinea D’Alessio.
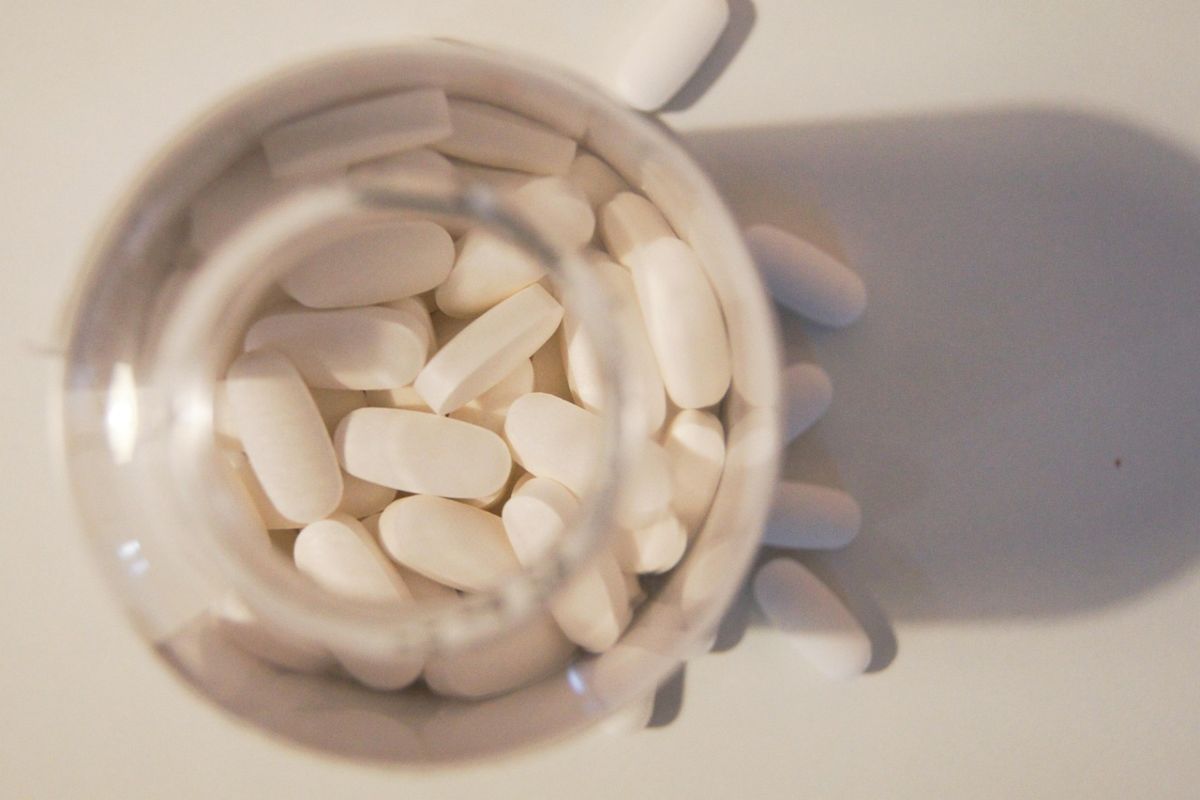
Il medico fa anche riferimento alla disregolazione dell’insulina, tipica dei soggetti con insulino-resistenza, spesso in sovrappeso. “Quando l’insulina non agisce correttamente, il glucosio non entra nelle cellule, e il cervello interpreta questo come carenza di energia. Risultato: aumenta la sensazione di fame, anche subito dopo un pasto completo”, chiarisce lo specialista.
Un altro fattore da non sottovalutare riguarda i meccanismi neurologici del cervello. Alcuni studi recenti dell’Università di Padova hanno messo in relazione il nucleo arcuato dell’ipotalamo, che regola la sazietà, con alterazioni da stress e da uso eccessivo di zuccheri raffinati. Questo crea una sorta di dipendenza comportamentale, simile a quella che si sviluppa con sostanze come la nicotina. “Non si parla di patologie gravi”, precisa l’endocrinologo, “ma di squilibri che si possono correggere con interventi personalizzati, che non sempre prevedono una dieta restrittiva”.
Quando la fame continua è un sintomo e non un problema di volontà
Il senso di fame incontrollato non va ignorato, soprattutto se si presenta più volte al giorno, anche in assenza di sforzi fisici o stress particolari. Il primo passo, secondo gli specialisti, è analizzare il contesto ormonale e metabolico della persona. Un semplice esame del sangue per valutare leptina, insulina e glicemia può già fornire indizi chiari.
D’Alessio racconta il caso di una donna di 34 anni, in normopeso, che si sentiva costantemente affamata. “Aveva provato varie diete ma peggiorava sempre. Dopo le analisi, è emersa una forma lieve di ipoglicemia reattiva. Correggendo i picchi glicemici e lavorando sulla qualità dei carboidrati assunti, in due settimane il problema si è risolto”, dice il medico.
Ci sono poi i casi legati a condizioni tiroidee, come l’ipotiroidismo subclinico. Anche lievi alterazioni della tiroide possono modificare il metabolismo basale e il tono dell’umore, contribuendo a una percezione distorta del senso di fame. “In alcuni soggetti, la fame è un sintomo secondario del corpo che cerca di compensare una spinta energetica mancante”, spiega D’Alessio.
In altri casi ancora, entrano in gioco i fattori psicologici. Lo stress cronico, la deprivazione di sonno, l’ansia o la depressione mascherata sono condizioni che possono alterare i segnali dell’appetito, portando a un consumo continuo di cibo come risposta automatica e consolatoria. Il problema, in questi contesti, non è mai solo “quello che si mangia”, ma il perché lo si fa.
L’endocrinologo invita chi vive questo tipo di disagio a non colpevolizzarsi. “Spesso ci si accusa di mancanza di forza mentale, quando invece si è vittime di un sistema biochimico alterato. E come ogni problema fisiologico, va studiato, capito, e trattato nel modo giusto, con l’aiuto di un professionista”, conclude.

